Prodezze della guerra asimmetrica. Un po’ di droni, un po’ di missili e un po’ di imboscate delle milizie Houthi stanno mandando in rovina l’invasione dello Yemen da parte della terza potenza del pianeta, dopo Stati Uniti e Cina, per spesa militare. L’Arabia Saudita spende 68 miliardi di dollari all’anno – l’8,8 per cento del suo Pil, primato mondiale – per armare una forza che da quattro anni non è in grado di prevalere su una congerie di combattenti straccioni, privi di aviazione, carri armati e difese antiaeree.
Le truppe reali combattono con il solido appoggio logistico e di intelligence americano, e tutto ciò che sono riusciti a fare finora è una serie di schifose stragi di civili nonché generare una crisi umanitaria da fame, sete e malattie che si è portata via 80 mila vite e sta facendo indignare il mondo intero. Contemporaneamente, i droni e i missili di qualche giorno fa – il cui lancio è stato rivendicato dagli yemeniti – sono penetrati nello spazio aereo saudita facendosi beffa del sistema di difesa antimissile made in Usa Patriot e hanno distrutto il principale impianto petrolifero del Paese, dimezzandone la capacità produttiva e riducendo del 5 per cento l’offerta mondiale di petrolio.
L’ attacco ha scioccato la monarchia e Washington al punto che non sono stati in grado di articolare una risposta immediata contro i presunti autori, né di fornire una giustificazione decorosa di quanto accaduto. Ma l’insegnamento impartito da questi fatti è apparso subito molto chiaro: il Regno d’Arabia Saudita è incapace sia di attaccare sia di difendersi decentemente perché non è in grado di usare le armi che possiede e che ha acquistato a caro prezzo. E perché non è una vera nazione né uno Stato. È una pompa di benzina postmoderna (tirannia medievale più rendita finanziaria), e vulnerabilissima, che riesce a stare in piedi solo perché paga un enorme costo di protezione agli Stati Uniti, o meglio, all’élite plutocratico-militare di quel Paese.
Gli Usa non hanno più bisogno del petrolio saudita. La tecnologia fracking li ha resi indipendenti dalle importazioni di idrocarburi e ha mandato in soffitta la dottrina Carter secondo la quale gli Stati Uniti avrebbero il diritto di difendere anche con la forza il loro approvvigionamento energetico dal Medioriente. Ma il legame tra la casa di Saud e l’America che conta è rimasto. Si basa sulla fornitura di armamenti e sul riciclaggio della rendita estrattiva tramite Wall Street e petrodollaro, e non va sottovalutato: è stato proprio l’11 settembre 2001 a dimostrarne la forza. 15 dei 19 attentatori erano sauditi, ma gli affari della famiglia Bush con la dinastia dei Saud hanno contribuito a deviare prima contro l’Afghanistan e poi contro l’Iraq la vendetta americana: Dollar First! Il tema è stato riassunto da Trump in campagna elettorale quando ha dichiarato che l’Arabia Saudita non è un alleato, ma spende centinaia di miliardi di dollari in armamenti americani. Perciò “è la nostra vacca da latte, e quando non sarà più capace di produrne, la macelleremo”. Il problema ora è che, invadendo lo Yemen e facendosi fare a pezzi senza reagire metà della sua industria petrolifera la settimana scorsa, la vacca si è macellata da sola. A beneficio di chi? Non certo degli Stati Uniti, che non possono pensare di raddoppiare le vendite di armi a un cliente che ha già raggiunto i propri limiti di esborso. E che, non sapendole usare, deve essere protetto d’ora in poi con un impegno militare diretto.
Il maggiore beneficiario immediato della palese vulnerabilità saudita è senza dubbio l’Iran, che è sia uno Stato che una nazione, nonché la massima potenza regionale da un paio di migliaia di anni. Potenza non aggressiva, che non inizia una guerra da 500 anni e che ha intrapreso da poco un percorso di riavvicinamento all’Occidente interrotto dall’avvento di Trump. L’idea, coltivata dai sauditi negli ultimi decenni, di poter seriamente competere con l’Iran per la supremazia nel Golfo e nella regione, è andata adesso in frantumi. Per di più è evidente che una guerra tra Arabia Saudita e Iran durerebbe poche settimane, e anche l’abbandono dei Patriot e la corsa all’acquisto degli S-300 russi si scontrerebbe con gli stessi ostacoli.
La palla ora è tutta nel campo di Washington. Ma il beneficiario di più lungo periodo della débâcle saudita è la pace internazionale. La guerra tra Usa e Iran era già improbabile perché non favorita né dal Congresso né dal Pentagono né dallo stesso Trump. E neppure, ovviamente, dall’Iran e dagli europei, impegnati a mantenere il Trattato nucleare del 2015. E le guerre non scoppiano per caso. Occorre che almeno una delle due parti sia fortemente decisa a iniziarla. Si è aperto così uno spazio ulteriore per una soluzione non militare dello scontro tra Stati Uniti e Iran. Ed è paradossale che stiamo tutti ad aspettare, a questo punto, l’esito finale del confronto tra l’anima isolazionista e quella bullista di un presidente americano lontano 7mila chilometri dal Medioriente.





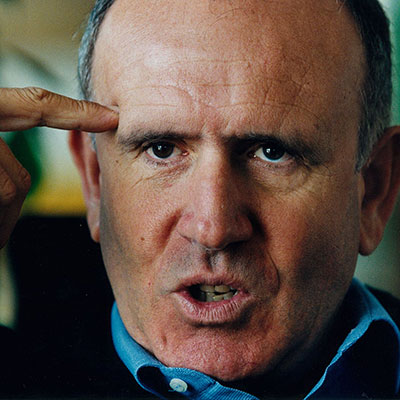 Non sono una persona complicata. La mia vita pubblica ruota intorno a due cose: il tentativo di capire ciò che mi circonda, da sociologo, e il tentativo di costruire un mondo più decente, da intellettuale e militante politico.
Non sono una persona complicata. La mia vita pubblica ruota intorno a due cose: il tentativo di capire ciò che mi circonda, da sociologo, e il tentativo di costruire un mondo più decente, da intellettuale e militante politico.




